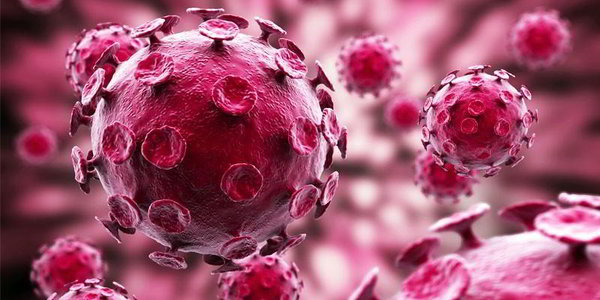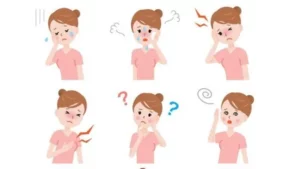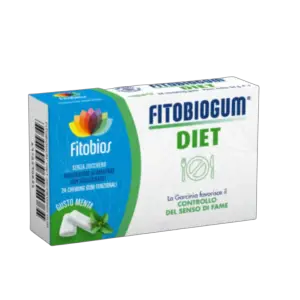Epatite C: cos’è e come prevenirla? Quali sono le cause dell’Epatite C e quali trattamenti mettere in atto in caso di contagio? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande ma è necessario fare prima un po’ di chiarezza sulla patologia.
L’Epatite C è un’infezione causata dal virus HCV (Hepacavirus appartenente alla famiglia Flaviviridae) che si replica nel fegato dell’uomo causandone una progressiva infiammazione. Questa, nel corso del tempo, può evolversi in cirrosi o addirittura in carcinoma epatocellulare, una grave forma di tumore epatico.
Del virus HCV sono state identificate sei varianti genotipiche che differiscono per distribuzione geografica e virulenza. Da sottolineare che lo stesso soggetto può essere infettato anche da più di un genotipo del virus. Come questi genotipi condizionino il decorso della malattia non è ancora chiaro ma rispondono certamente in modo diverso alle terapie antivirali.
Epatite C: Cos’è? Epidemiologia
L’epatite C è, dunque, un’infezione grave tanto che si stima che circa 71 milioni di persone in tutto il mondo ne siano affette. In particolare quella cronica e un numero molto alto di queste sviluppano cirrosi o forme tumorali del fegato. Proprio a causa di queste gravi conseguenze dell’infezione ogni anno muoiono ben 399.000 persone. Questi sono i dati raccolti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha tracciato anche una distribuzione geografica della diffusione del virus. L’Europa e le regioni orientali del Mediterraneo risultano le più colpite a causa dell’aumentato uso delle droghe iniettabili. Inoltre, anche il genotipo varia a seconda dell’area geografica:
- A livello globale prevale il genotipo 1
- In Italia il sottotipo 1b che si ritrova nel 51% dei pazienti
L’incidenza dell’infezione nei Paesi occidentali è diminuita significativamente negli ultimi decenni grazie al miglioramento delle prestazioni sanitarie e all’ottimizzazione dei test di screening pretrasfusionali. In Italia, i soggetti con epatite C diagnosticata sono circa 300.000 e purtroppo molte altre persone sono inconsapevoli di essere state infettate dal virus e quindi non è possibile stimare un numero esatto.
Epatite C: Contagio
L’Epatite C si trasmette prevalentemente per via parenterale: cioè quando il sangue di una persona sana viene a contatto con il sangue di una persona infetta. Le cause possono essere molteplici e proprio per questo motivo non è sempre facile stabilire quale sia stata la sorgente di infezione. Vediamo quali sono le cause più comuni attraverso un elenco specifico delle cause del contagio:
- un’inadeguata assistenza sanitaria
- l’uso di aghi per la somministrazione di droghe
- farmaci iniettabili
- la pratica di tatuaggi e piercing in condizioni di non sterilità ecc.
Oggi, i test di screening eseguiti sul sangue dei donatori hanno ridotto significativamente i casi di contagio che in passato si registravano a seguito di trasfusioni e un’analoga considerazione può essere fatta per il trapianto di organi.
Il virus è sessualmente trasmissibile ma con un’efficienza minore rispetto a quello dell’Epatite B e anche la trasmissione verticale da madre a figlio è molto rara (i casi di contagio non raggiungono il 5%). Altri fattori di rischio possono essere:
- l’assunzione di alcolici
- l’età: se l’infezione viene contratta quando da un soggetto non più tanto giovane, il grado di infiammazione e la presenza di altre patologie nel soggetto infetto
Epatite C: Sintomi
Il virus ha un periodo di incubazione compreso tra 6 e 9 settimane. Normalmente la fase acuta dell’infezione non manifesta sintomi e non è accompagnata da ittero cioè dalla condizione in cui la cute e le mucose tendono ad assumere una colorazione giallastra a causa dell’eccessiva concentrazione sierica di bilirubina. Nella maggior parte dei casi, l’epatite acuta ha un decorso clinico breve ma se non si risolve da sola nel giro di sei mesi può progredire nella forma cronica. Si stima che l’80% dei casi di epatite C tenda a cronicizzarsi e tra i sintomi più comuni si elencano:
- malessere generale
- nausea e vomito
- inappetenza e anoressia
- febbre
- dolori addominali
- ittero
- stati di depressione e ansia
Circa il 30% dei soggetti con Epatite C cronica sviluppa cirrosi: cioè lo stato patologico in cui il fegato presenta quantità eccessive di tessuto fibroso a causa dei ripetuti tentativi di difendersi da patologie che lo hanno danneggiato nel tempo. Al contrario, l’epatocarcinoma (forma tumorale del fegato) si riscontra in una percentuale molto più bassa, compresa tra l’1 e il 4%. Infine, l’Epatite C fulminante, caratterizzata dalla morte cellulare del parenchima epatico, è molto rara. Infatti, i casi registrati riportano una percentuale dello 0,1%.
In aggiunta alla cirrosi e ai tumori del fegato si possono sviluppare altre complicanze a seguito dell’infezione da HCV. Tra queste, le varici esofagee e gastriche responsabili di stati emorragici e della formazione di asciti cioè dell’accumulo di liquidi nella cavità addominale. Il danneggiamento dei tessuti epatici poi fa perdere al fegato gran parte delle sue normali funzioni come quella di smaltire le sostanze tossiche che tendono così ad accumularsi e a causare encefalopatia epatica. In questo caso, ad essere interessato dallo stato patologico non è solo il fegato ma anche il cervello che viene raggiunto da queste sostanze tossiche. I soggetti colpiti mostrano:
- confusione mentale
- sonnolenza
- disorientamento
- disturbi della personalità e dell’umore
Epatite C: Cura e Trattamento
Il trattamento si basa su una terapia di supporto che può impedire lo sviluppo dell’Epatite cronica. Purtroppo, il costo elevato di questi trattamenti ne ostacola l’applicazione durante la fase acuta. Infatti, il suggerimento è quello di monitorare i soggetti nei primi sei mesi dell’infezione confidando nella guarigione spontanea. Se l’infezione non si risolve da sola, evolvendosi quindi nella forma cronica, è necessario agire farmacologicamente.
Nel complesso, le terapie in atto portano alla guarigione nel 95% dei casi e se si utilizzano nella fase acuta consentono persino l’eradicazione del virus. Da sottolineare il fatto che questi farmaci ad azione diretta presentano effetti collaterali del tutto trascurabili.
Le terapie di trattamento dell’Epatite C sono in continua evoluzione perché sempre più farmaci antivirali sono in fase di sviluppo. Tuttavia, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità prevedono generalmente una terapia standard basata su antivirali ad azione diretta. In particolare:
- sofosbuvir
- daclatasvir
- la combinazione di sofosbuvir/ledipasvir
Il primo è un inibitore dell’enzima polimerasi e agisce contro i sei genotipi del virus. Daclatasvir, invece, è un inibitore della proteina non strutturale 5A e ledipasvir ha il ruolo di inibire le proteasi.
La prevenzione per l’Epatite C
Come per ogni condizione patologica, il trattamento più efficace è la prevenzione che nel caso dell’Epatite C assume un’importanza molto più rilevante dato che la vaccinazione non è disponibile. Il continuo e repentino mutare del virus rende, infatti, sempre più difficile lo sviluppo di un potenziale vaccino anti-HCV. Pertanto è necessario osservare quelle norme igieniche che permettono di evitare l’infezione e che costituiscono la cosiddetta prevenzione primaria:
- evitare di condividere oggetti personali che potrebbero prendere contatto con il sangue come rasoi, forbicine, siringhe, spazzolino da denti
- usare il profilattico durante un rapporto sessuale
- prestare attenzione alle condizioni igieniche quando si fanno tatuaggi, piercing o altri trattamenti estetici che prevedono l’utilizzo di aghi
Invece, la prevenzione secondaria e quella terziaria nei soggetti infettati prevedono:
- programmi di informazione sui trattamenti farmacologici
- vaccinazione contro il virus dell’Epatite A e B per prevenire la coinfezione (più infezioni contratte contemporaneamente) con questi virus e proteggere il fegato
- un tempestivo e adeguato trattamento antivirale
- appropriato monitoraggio dei pazienti per diagnosticare il virus in tempi brevi e prevenire lo sviluppo di forme croniche
Come diagnosticare l’Epatite C?
Diagnosticare l’Epatite C durante la fase acuta è molto difficile dato che si presenta asintomatica e i soggetti affetti sono inconsapevoli di essere stati infettati. La diagnosi viene fatta quando ormai l’infezione ha danneggiato seriamente il fegato e i sintomi sono evidenti. La diagnosi si basa essenzialmente sulla:
- valutazione clinica dei sintomi
- funzionalità del fegato
- determinazione del tempo di protrombina e INR (international normalized ratio).
Il tempo di protrombina indica con quanta velocità la protrombina viene convertita in trombina ed è utile per individuare eventuali anomalie nella coagulazione del sangue alla cui regolazione prendono parte anche delle proteine del fegato. Anche il test dell’INR misura i tempi di coagulazione del sangue, ecco perché in caso di epatite C o di qualsiasi altra disfunzionalità epatica si prendono in considerazione questi tipi di analisi.
La ricerca degli anticorpi anti-HCV nel siero permette di determinare se un soggetto è stato infettato dal virus. Se lo screening è positivo successivamente si esegue un test basato sull’RNA del virus al fine di confermare lo stato cronico dell’infezione. Questo è utile per capire se l’infezione persiste oppure se il sistema immunitario è riuscito a sconfiggere spontaneamente il virus senza la necessità di intervenire farmacologicamente.
In alcuni casi, si esegue anche una biopsia epatica che risulta utile, ad esempio, per valutare lo stato dell’infiammazione e determinare quindi il progredire della patologia nonché la presenza o l’assenza di altre patologie a carico del fegato. Tuttavia, la biopsia epatica è una tecnica molto invasiva che viene man mano sostituita dall’applicazione di test diagnostici sierologici molto più immediati. In caso di cronicizzazione dell’infezione è necessario accertare lo stato di avanzamento del virus e di conseguenza i danni causati al fegato. Questo accertamento è indispensabile per valutare la terapia da intraprendere.